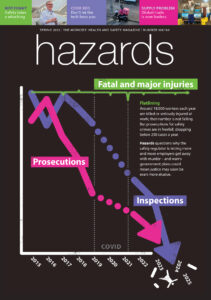Immagine di John Englart (Takver), Creative Commons 2.0
Fonte: Znetwork.org
Sebbene il cambiamento climatico non causi direttamente conflitti, rende più probabile che la violenza si verifichi e sia più intensa. Gli effetti del cambiamento climatico agiscono come “moltiplicatori di minacce” che intensificano i modelli di conflitto già esistenti. Il legame tra cambiamento climatico e conflitto è ormai ben consolidato, ma la maggior parte delle esplorazioni di questa connessione si trovano in studi accademici che probabilmente risulteranno noiosi per il grande pubblico.
Un resoconto molto più vivace di questo legame problematico è offerto nel libro di Peter Schwartzstein, recentemente pubblicato, “The Heat and the Fury: On the Frontlines of Climate Violence”. Schwartzstein è un giornalista e un ricercatore non residente presso il Center for Climate & Security di Washington DC. Il suo libro incorpora la ricerca scientifica sul nesso cambiamento climatico/conflitto, ma si basa in gran parte sull’esperienza pluriennale di Schwartzstein nel reportage da, come lui stesso afferma, “le prime linee della violenza climatica”.
Il cambiamento climatico ha soppiantato vecchie certezze, sfidando la conoscenza intergenerazionale e le strutture tradizionali dell’autorità. A Boki Saboudo, nel Senegal nord-orientale, Schwartzstein incontra Idrissa Ba, il capo del villaggio. La sua posizione lo rende la persona a cui i pastori locali si rivolgono tradizionalmente per un consiglio, un compito sempre più complicato oggigiorno. Come spiega Ba all’autore, “Inizi a chiederti se ciò che sai è ancora utile”, aggiungendo che “il clima non è normale. Le piogge non sono normali”. [1]
I modelli di precipitazioni altamente fluttuanti hanno portato più anni di piogge deboli, costringendo i pastori ad abbandonare i pascoli esauriti prima nell’anno e a trasferirsi nelle aree abitate dagli agricoltori quando stanno ancora completando il raccolto. Gli agricoltori erano soliti accogliere il bestiame come fertilizzante naturale e gli permettevano di mangiare dai campi. Con l’arrivo dei fertilizzanti artificiali nell’agricoltura tradizionale e le rese dei raccolti più piccole dovute alle piogge irregolari, la coabitazione tra pastori e agricoltori spesso crolla e il bestiame soffre la fame. Come spiega Schwartzstein, i gruppi jihadisti nel Sahel hanno tratto profitto da questa disperazione, reclutando in modo eccessivamente proporzionale tra i pastori.
Se il cambiamento climatico è un “moltiplicatore di minacce”, è in parte perché agisce come un acceleratore di disuguaglianze di lunga data nella ricchezza e nel potere politico. Il World Economic Forum nota che “i paesi con il reddito più basso producono un decimo delle emissioni, ma sono quelli più pesantemente colpiti dal cambiamento climatico”. Schwartzstein offre un buon esempio di questa dinamica nel suo capitolo sul Sudan, un paese responsabile solo dello 0,06% delle emissioni globali di CO₂. Gli abitanti dei villaggi sudanesi hanno subito lo sfollamento o sono rimasti senza acqua per l’agricoltura, poiché i paesi del Golfo investono pesantemente in importanti sfruttamenti agricoli in Sudan dopo aver riempito le loro casse con l’esportazione di combustibili fossili inquinanti.
All’interno delle nazioni più colpite dal cambiamento climatico, i costi sono anche distribuiti in modo non uniforme. Il capitolo di “The Heat and the Fury” dedicato al Nepal e alla sua crisi idrica lo mostra chiaramente. Mentre l’agricoltura di sussistenza vacilla in Nepal a causa del cambiamento climatico, sempre più nepalesi stanno abbandonando le aree rurali montuose per cercare lavoro nella capitale, Kathmandu. Questi migranti interni finiscono spesso nelle baraccopoli della città, che lo stato non ha collegato correttamente alla rete idrica.
Come racconta Schwartzstein, quando arriva la stagione secca, questi quartieri dipendono dagli “uomini cisterna”, che distribuiscono l’acqua a caro prezzo e spingono molti acquirenti a indebitarsi. Gli “uomini cisterna” possono arrivare a tanto per difendere il loro modello di business. È comune per loro raggiungere accordi con funzionari corrotti per impedire che le condutture idriche scorrano nelle aree in cui vendono il loro prodotto. In queste condizioni di potere statale indebolito, la miseria dei migranti interni diventa la fortuna di uomini d’affari e funzionari senza scrupoli. Una coppia che vive nelle baraccopoli di Kathmandu e dipende dagli “uomini cisterna” per l’acqua potabile dice all’autore: “Qualunque cosa costi, paghiamo noi. Non abbiamo scelta”. [2] Non tutti affrontano la situazione con queste dimissioni, tuttavia, poiché alcuni dipendenti statali dell’acqua sono stati picchiati nelle baraccopoli della città.
Schwartzstein affronta alcuni casi relativamente noti, come le radici ambientali dell’espansione dell’ISIS in Iraq. Altri racconti, tuttavia, sorprenderanno sicuramente la maggior parte dei lettori. Uno di questi è il capitolo dedicato ai pirati delle Sundarbans del Bangladesh. Situate tra l’India orientale e il Bangladesh sud-occidentale, le Sundarbans sono un’area di foresta di mangrovie nel delta del Gange che si estende per 10.000 km2 (3.900 miglia quadrate), rendendola la più grande foresta di mangrovie del mondo. Nelle Sundarbans, il cambiamento climatico ha portato all’innalzamento del livello del mare e alla diminuzione dei flussi fluviali che danneggiano le attività agricole.
Di conseguenza, alcuni contadini tentano la fortuna come pescatori e raccoglitori di miele nelle acque dei Sundarbans. Una volta lì, rischiano di perdersi nella confusa vastità di alberi e acqua o di cadere preda dei jaladoshyu , come vengono chiamati localmente i pirati. Queste bande di pirati sono composte da criminali di lunga data, ma anche da ex pescatori o contadini in fuga da montagne di debiti. I jaladoshyu fanno soldi con il bracconaggio della tigre del Bengala in via di estinzione o con il rapimento di sfortunati pescatori. In una pratica raccapricciante, i pescatori rapiti vengono talvolta mutilati per aumentare ulteriormente la pressione sui parenti a cui viene chiesto di riscuotere il riscatto. Si dice che la famigerata banda di pirati Master Bahini (Master Group) abbia avuto guadagni annuali di circa 60 milioni di taka (732.000 $). Per fare un paragone, lo stipendio mensile medio di un lavoratore in una fabbrica tessile in Bangladesh è di 8.300 taka (75 $).
I paesi più ricchi sono stati finora relativamente isolati dai peggiori impatti climatici, ma questo sta iniziando a cambiare. E nonostante questi paesi siano meglio dotati del tipo di risorse economiche e infrastrutturali che sono fondamentali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, potrebbero essere destinati a un brusco risveglio. Schwartzstein menziona il lavoro di studiosi che sostengono, in modo un po’ controintuitivo, che potrebbe essere nei paesi ricchi che i governi avranno maggiori difficoltà a mantenere la pace sociale in tempi di catastrofici cambiamenti climatici. Come scrive l’autore, “La frustrazione popolare nei confronti del governo raggiunge spesso il picco quando i funzionari non riescono a fornire servizi a cui i cittadini si sono abituati. Se questo è il caso in Occidente, noi, con i nostri generalmente forti sensi di diritto, potremmo avere un sacco di problemi”. [3]
Oxfam International nota che i paesi ricchi sopravvalutano notevolmente i finanziamenti per il clima che forniscono ai paesi più poveri. Sebbene nel 2022 siano stati annunciati 116 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima, la maggior parte di questi fondi è arrivata sotto forma di prestiti a tassi di mercato redditizi. Il “vero valore” dei finanziamenti per il clima forniti dai paesi ricchi nel 2022 era in realtà compreso tra 28 e 35 miliardi di dollari secondo le stime di Oxfam. E questi valori probabilmente diminuiranno nei prossimi anni. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno fornito circa l’8% dei fondi globali per i finanziamenti per il clima. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ritirato il suo paese dall’accordo sul clima di Parigi per la seconda volta dopo essere tornato in carica nel gennaio 2025, ha sospeso gran parte dei finanziamenti all’USAID. Questa agenzia governativa, responsabile degli aiuti all’estero, fornisce circa un terzo dei finanziamenti per il clima degli Stati Uniti. Washington ha anche recentemente annullato 4 miliardi di dollari di impegni statunitensi al Green Climate Fund, il più grande fondo per il clima al mondo.
L’Europa, immersa nei piani per un aumento della spesa per la difesa, difficilmente riuscirà a compensare la diminuzione dei contributi degli Stati Uniti al finanziamento per il clima. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato a novembre 2024 che il suo nuovo governo avrebbe “rinnovato la leadership climatica del Regno Unito”. Due settimane fa, tuttavia, Starmer ha annunciato che sta pianificando di finanziare l’espansione del bilancio militare britannico attuando tagli di oltre 6 miliardi di sterline (7 miliardi di dollari) all’anno. Non è chiaro cosa accadrà al finanziamento per il clima del Regno Unito quando i tagli entreranno in vigore nel 2027. La futura perdita di influenza di Londra nei negoziati sul clima a causa dei tagli agli aiuti è stato uno degli aspetti menzionati da Anneliese Dodds nella sua lettera di dimissioni da ministro dello sviluppo internazionale della Gran Bretagna.
Potrebbe rappresentare una magra consolazione in tempi di tagli importanti agli aiuti per la mitigazione del cambiamento climatico, ma alcuni dei successi nella costruzione della pace ambientale che Schwartzstein menziona nel libro sono poco costosi. La costruzione della pace ambientale si riferisce alla cooperazione su questioni ambientali tra gruppi sociali distinti che porta a relazioni più pacifiche. Schwartzstein descrive un esempio di successo di costruzione della pace ambientale nel Senegal settentrionale, in una delle aree con conflitti ricorrenti tra pastori e agricoltori. Nel caso documentato da Schwartzstein, un pastore aveva ucciso un altro pastore durante una disputa per i pascoli scarsi. Una ONG internazionale con una forte presenza locale è intervenuta nel conflitto riunendo rappresentanti dei diversi villaggi della zona dopo che erano stati scelti dalle rispettive comunità. Questi rappresentanti si sono riuniti e sono riusciti a concordare delle regole sul numero massimo di mandrie e un risarcimento appropriato in caso di violazioni delle regole.
Di sicuro, il problema principale che queste comunità stanno affrontando, vale a dire le piogge irregolari che portano all’impoverimento dei pascoli, rimane irrisolto. Ma questi sforzi di costruzione della pace ambientale, spiega Schwartzstein, si sono espansi nel Sahel e hanno contribuito a una diminuzione della violenza. La chiave, nota, è che la maggior parte di questi progetti sono “guidati dalla gente del posto e quindi sono più in sintonia con le esigenze e i desideri dei destinatari previsti rispetto a molti interventi dall’alto”. [4]
“The Heat and the Fury” è il primo libro di Schwartzstein. Data la sua abile combinazione di aneddoti personali, analisi dei fatti e impressionanti resoconti sul campo, non possiamo che sperare che ne usciranno altri.
Appunti
[1] Peter Schwartzstein, The Heat and the Fury: On the Frontlines of Climate Violence (Londra: Footnote Press, 2024), p. 151.
[2] Ivi, p. 124.
[3] Ivi, p. 229.
[4] Ivi, p. 270.
ZNetwork è finanziato esclusivamente dalla generosità dei suoi lettori.