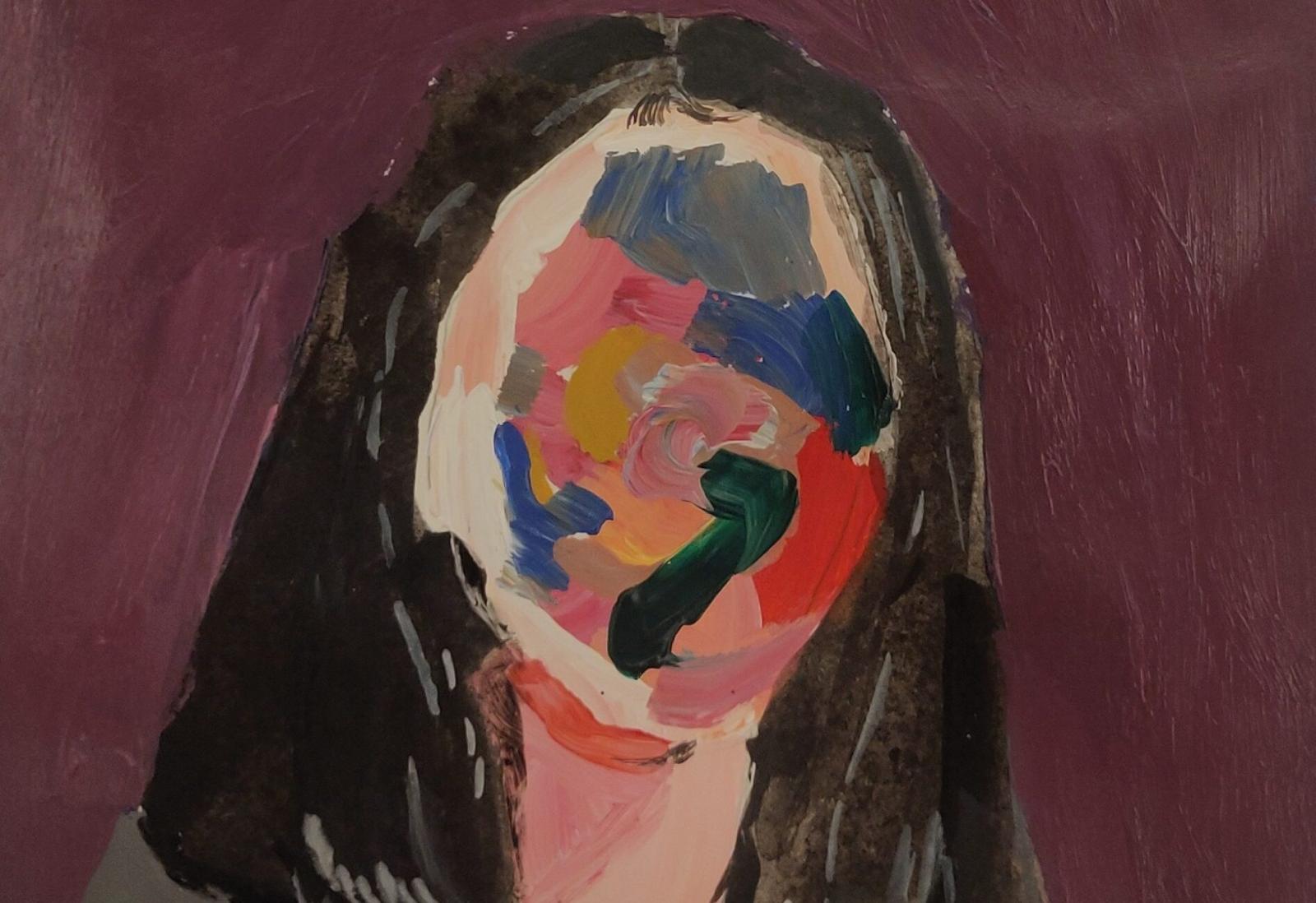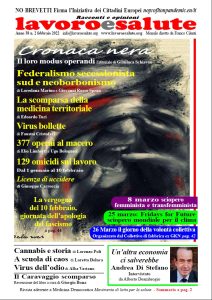Fonte Ministero Salute
Sono 728.338 le persone con problemi di salute mentale assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020. I pazienti di sesso femminile sono il 53,6%.
La composizione per età riflette l’invecchiamento della popolazione generale, con un’ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (69,0%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni mentre la più alta concentrazione si ha nelle classi 45-54 anni e 55-64 anni (46,8% in entrambi i sessi); le femmine presentano, rispetto ai maschi, una percentuale più elevata nella classe > 75 anni (6,7% nei maschi e 10,7% nelle femmine).
Nel 2020 i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l’anno con i Dipartimenti di Salute Mentale sono 253.164, di cui il 91,8% ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita.
Questi alcuni dati contenuti nel Rapporto sulla salute mentale 2020, rilevazione, istituita dal decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, e che costituisce, a livello nazionale, la più ricca fonte di informazioni sugli interventi sanitari e socio-sanitari dell’assistenza alle persone adulte con problemi di salute mentale e alle loro famiglie.
Il Rapporto sulla salute mentale offre al lettore una panoramica delle evidenze emerse dalle varie fonti informative disponibili. I dati sono rilevati attraverso il SISM (Sistema Informativo Salute Mentale) che rappresenta lo strumento cardine per programmare a livello dell’erogazione dell’assistenza, regionale e locale, nonché per disegnare strategie di livello nazionale, modulate su tempi medio-lunghi, in considerazione dei trend della prevalenza dei principali disturbi mentali, a cui sono associati diversi gradi di disabilità, sofferenze individuali e della rete familiare, nonché pesanti costi economici e sociali.
I dati che vengono presentati nel Rapporto, riferiti all’anno 2020, riguardano i servizi per gli adulti, le caratteristiche degli utenti e le patologie, le attività dei servizi di salute mentale, le risorse di personale, l’attività psichiatrica ospedaliera, il consumo di farmaci e i costi dell’assistenza psichiatrica.
La pubblicazione contiene anche schede regionali con la rappresentazione grafica di un gruppo selezionato di indicatori, che descrivono le risorse a disposizione, l’utenza trattata, l’attività ospedaliera e territoriale di ogni regione.
Leggi:









 (
(